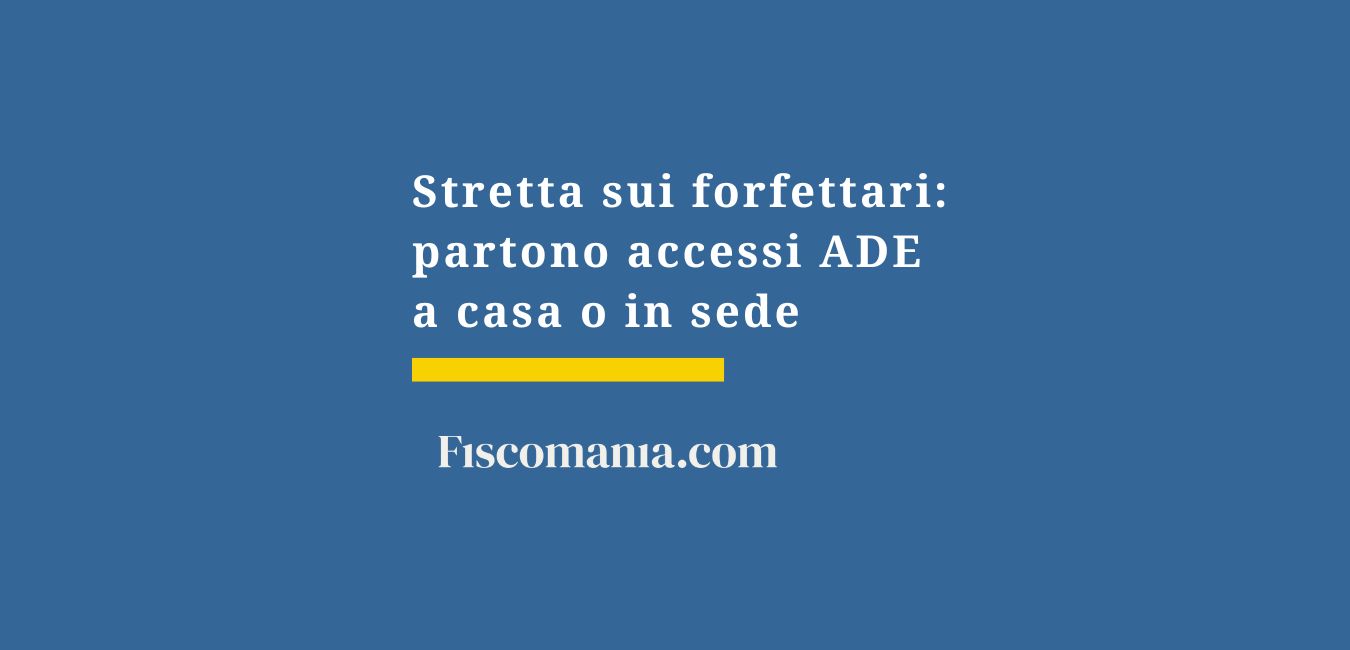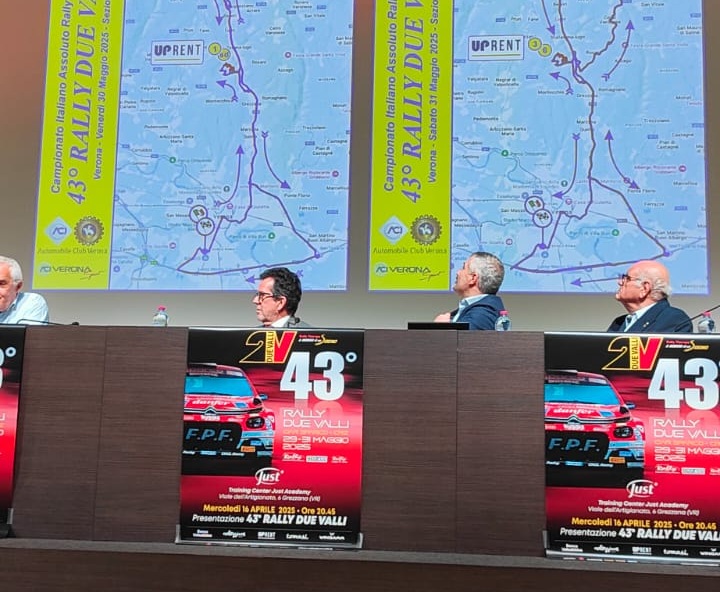Il processo a Socrate, “il più saggio dei Greci”
Correva l'anno 399 a.C. quando il filosofo Socrate, ormai settantenne, fu portato in giudizio ad Atene, accusato dai suoi nemici di un grave reato: empietà. Conosciamo bene il testo dell'accusa, che diceva così: «Meleto, figlio di Meleto, del demo di Pitto, presenta denuncia sotto giuramento, accusando Socrate, figlio di Sofronisco, del demo di Alopecè: Socrate commette il reato di non riconoscere gli dei in cui crede la città e introduce nuove divinità. Inoltre delinquere corrompendo i giovani. Pena richiesta: la morte».Il reato di empietà (asébeia) era stato introdotto nella legislazione ateniese alcuni decenni prima. Un certo Diopites, forse un sacerdote o un indovino, lo aveva proposto durante la guerra del Peloponneso, e da allora era già stato applicato in altri casi, quasi sempre con l'intenzione di perseguire un rivale politico. Questo fu il caso di Socrate. Il suo accusatore, Meleto, un giovane poeta o un tragico di scarso valore, agì per conto di altri due personaggi chiamati Anito e Licone, ben noti come politici democratici ad Atene.Lo scopo ultimo dell'accusa era chiaro: volevano mettere a tacere per sempre un individuo troppo fastidioso come critico delle tradizioni e che molti identificavano come un sofista in più, cioè come uno di quei falsi saggi che avevano introdotto il disinteresse per la religione e idee inquietanti tra i giovani. Altri ricordano che tra gli amici e i seguaci di questo strano “saggio” di strada c'erano il grande Alcibiade e il tirannico Critias, due politici che molti consideravano nemici della democrazia.Erano passati cinque anni dalla fine della guerra del Peloponneso e, sebbene un'amnistia generale avesse posto fine alle divergenze tra il partito oligarchico - che nel 404 a.C. aveva patrocinato il regime dei Trenta Tiranni - e la fazione popolare, che riuscì presto a ripristinare la democrazia, senza dubbio c'erano ancora molti rancori nascosti tra gli ateniesi. In un simile clima e con tali note di sottofondo si svolse il processo dell'inquietante Socrate.Tranquillo e provocatorioSocrate fu processato da un tribunale popolare. Quest'ultimo, composto da 500 o 501 cittadini, doveva pronunciare la sentenza dopo aver ascoltato l'accusatore e l'accusato. Platone e Senofonte, due dei discepoli di Socrate , raccolsero il lungo discorso che il filosofo pronunciò in quell'occasione. Deciso a evitare qualsiasi gesto di supplica, Socrate espose il comportamento che aveva mantenuto per tutta la vita, che a suo avviso era sempre stato al servizio della verità e dell'educazione dei suoi concittadini.Dichiarò di non aver mai agito come sofista, poiché non dava lezioni né le faceva pagare e non aveva una scuola, e che era sempre stato un buon cittadino. Come prova di quest'ultimo aspetto, ricordò la sua partecipazione alle battaglie di Potidea, Anfípolis e Delion, durante la guerra del Peloponneso. Negò anche di essere un nemico della democrazia, poiché si era rifiutato, affrontando così un pericolo personale, di obbedire a un mandato dei Trenta Tiranni.Socrate insisteva sul fatto che il suo scopo non era quello di intervenire negli affari e nei processi della democrazia, ma solo di perfezionare la morale dei cittadini esortandoli a preoccuparsi di conoscere l'essenziale. Da qui la sua abitudine di chiedere a tutti cosa fosse la virtù, la giustizia, la pietà, il vero bene, incoraggiandoli a cercare risposte a queste domande senza preoccuparsi del denaro o del potere. Socrate osò persino ricordare come l'oracolo di Delfi, consultato in una certa occasione dal suo vecchio amico Fedone, lo avesse riconosciuto come “il più saggio dei Greci”. All'inizio lui stesso non capì questa sentenza, finché non scoprì che era perché riconosceva di non sapere nulla.L'apologia pronunciata da Socrate doveva sembrare sconcertante e al tempo stesso un po' arrogante alla maggior parte dei giudici, che lo dichiararono colpevole, anche se solo per una piccola differenza di voti. Ad Atene, i condannati in questa prima votazione avevano il diritto di proporre una pena alternativa a quella precedentemente richiesta dall'accusa, che nel caso di Socrate era la morte.Una condanna unanimeIl filosofo pronunciò quindi un secondo discorso in cui riaffermò il suo atteggiamento e insistette nel presentarsi come un benefattore di tutti i suoi concittadini. In quanto tale, propose alla giuria di essere mantenuto nel Pritaneo (sede del governo di Atene), sovvenzionato dalla città come se fosse un eroe o un vincitore dei Giochi Olimpici. Socrate aggiunse che, per compiacere i suoi amici, avrebbe accettato di pagare una piccola multa, ma che non era disposto a cambiare comportamento, perché non temeva la morte.Inoltre, nell'Aldilà, la sua anima avrebbe potuto incontrare persone molto degne e continuare lì i suoi dialoghi: «Trascorrere il tempo esaminando e indagando su quelli di là, come ora su quelli di qua, per vedere chi di loro è saggio, e chi crede di esserlo e non lo è [...] sarebbe il massimo della felicità».Dopo q

Correva l'anno 399 a.C. quando il filosofo Socrate, ormai settantenne, fu portato in giudizio ad Atene, accusato dai suoi nemici di un grave reato: empietà. Conosciamo bene il testo dell'accusa, che diceva così: «Meleto, figlio di Meleto, del demo di Pitto, presenta denuncia sotto giuramento, accusando Socrate, figlio di Sofronisco, del demo di Alopecè: Socrate commette il reato di non riconoscere gli dei in cui crede la città e introduce nuove divinità. Inoltre delinquere corrompendo i giovani. Pena richiesta: la morte».
Il reato di empietà (asébeia) era stato introdotto nella legislazione ateniese alcuni decenni prima. Un certo Diopites, forse un sacerdote o un indovino, lo aveva proposto durante la guerra del Peloponneso, e da allora era già stato applicato in altri casi, quasi sempre con l'intenzione di perseguire un rivale politico. Questo fu il caso di Socrate. Il suo accusatore, Meleto, un giovane poeta o un tragico di scarso valore, agì per conto di altri due personaggi chiamati Anito e Licone, ben noti come politici democratici ad Atene.
Lo scopo ultimo dell'accusa era chiaro: volevano mettere a tacere per sempre un individuo troppo fastidioso come critico delle tradizioni e che molti identificavano come un sofista in più, cioè come uno di quei falsi saggi che avevano introdotto il disinteresse per la religione e idee inquietanti tra i giovani. Altri ricordano che tra gli amici e i seguaci di questo strano “saggio” di strada c'erano il grande Alcibiade e il tirannico Critias, due politici che molti consideravano nemici della democrazia.
Erano passati cinque anni dalla fine della guerra del Peloponneso e, sebbene un'amnistia generale avesse posto fine alle divergenze tra il partito oligarchico - che nel 404 a.C. aveva patrocinato il regime dei Trenta Tiranni - e la fazione popolare, che riuscì presto a ripristinare la democrazia, senza dubbio c'erano ancora molti rancori nascosti tra gli ateniesi. In un simile clima e con tali note di sottofondo si svolse il processo dell'inquietante Socrate.
Tranquillo e provocatorio
Socrate fu processato da un tribunale popolare. Quest'ultimo, composto da 500 o 501 cittadini, doveva pronunciare la sentenza dopo aver ascoltato l'accusatore e l'accusato. Platone e Senofonte, due dei discepoli di Socrate , raccolsero il lungo discorso che il filosofo pronunciò in quell'occasione. Deciso a evitare qualsiasi gesto di supplica, Socrate espose il comportamento che aveva mantenuto per tutta la vita, che a suo avviso era sempre stato al servizio della verità e dell'educazione dei suoi concittadini.
Dichiarò di non aver mai agito come sofista, poiché non dava lezioni né le faceva pagare e non aveva una scuola, e che era sempre stato un buon cittadino. Come prova di quest'ultimo aspetto, ricordò la sua partecipazione alle battaglie di Potidea, Anfípolis e Delion, durante la guerra del Peloponneso. Negò anche di essere un nemico della democrazia, poiché si era rifiutato, affrontando così un pericolo personale, di obbedire a un mandato dei Trenta Tiranni.
Socrate insisteva sul fatto che il suo scopo non era quello di intervenire negli affari e nei processi della democrazia, ma solo di perfezionare la morale dei cittadini esortandoli a preoccuparsi di conoscere l'essenziale. Da qui la sua abitudine di chiedere a tutti cosa fosse la virtù, la giustizia, la pietà, il vero bene, incoraggiandoli a cercare risposte a queste domande senza preoccuparsi del denaro o del potere. Socrate osò persino ricordare come l'oracolo di Delfi, consultato in una certa occasione dal suo vecchio amico Fedone, lo avesse riconosciuto come “il più saggio dei Greci”. All'inizio lui stesso non capì questa sentenza, finché non scoprì che era perché riconosceva di non sapere nulla.
L'apologia pronunciata da Socrate doveva sembrare sconcertante e al tempo stesso un po' arrogante alla maggior parte dei giudici, che lo dichiararono colpevole, anche se solo per una piccola differenza di voti. Ad Atene, i condannati in questa prima votazione avevano il diritto di proporre una pena alternativa a quella precedentemente richiesta dall'accusa, che nel caso di Socrate era la morte.
Una condanna unanime
Il filosofo pronunciò quindi un secondo discorso in cui riaffermò il suo atteggiamento e insistette nel presentarsi come un benefattore di tutti i suoi concittadini. In quanto tale, propose alla giuria di essere mantenuto nel Pritaneo (sede del governo di Atene), sovvenzionato dalla città come se fosse un eroe o un vincitore dei Giochi Olimpici. Socrate aggiunse che, per compiacere i suoi amici, avrebbe accettato di pagare una piccola multa, ma che non era disposto a cambiare comportamento, perché non temeva la morte.
Inoltre, nell'Aldilà, la sua anima avrebbe potuto incontrare persone molto degne e continuare lì i suoi dialoghi: «Trascorrere il tempo esaminando e indagando su quelli di là, come ora su quelli di qua, per vedere chi di loro è saggio, e chi crede di esserlo e non lo è [...] sarebbe il massimo della felicità».
Dopo questa arringa si tenne la seconda votazione, in cui la giuria lo condannò a morte con una maggioranza di 280 voti contro 220, una maggioranza molto più ampia della precedente. In un breve discorso di commiato, Socrate perdonò i giudici e insistette sul fatto che nessuno sapeva se la morte fosse un bene o un male.
La fine di un filosofo
Sebbene l'esecuzione dei condannati a morte fosse solitamente quasi immediata alla lettura del verdetto, nel caso di Socrate fu ritardata di un mese. Il processo aveva coinciso con le feste di Delia, durante le quali una nave andava da Atene all'isola di Delos per il festival in onore di Apollo.![]()
A quel tempo non era lecito giustiziare nessuno, e accadde che i venti ritardarono il ritorno della nave di quei trenta giorni. Durante questo periodo, gli amici poterono andare a trovare il prigioniero e parlare con lui. Nel dialogo di Platone intitolato Critone si racconta come i suoi discepoli gli proposero una facile fuga da quel carcere, cosa che Socrate rifiutò, perché voleva obbedire alle leggi della città in cui aveva sempre vissuto.
Nel Fedone, Platone racconta la conversazione di Socrate con i suoi amici nelle ultime ore della sua vita. Il filosofo cercò di consolarli discutendo dell'immortalità dell'anima, con vari argomenti e un racconto mitico sul giudizio delle anime nell'altra vita celeste. Alla fine, Socrate li salutò, bevve la cicuta e morì quando il veleno gli paralizzò il cuore. Prima lasciò una frase enigmatica: “Dobbiamo un gallo ad Asclepio!”, era ironia, perché Asclepio è il salvatore divino dalle malattie e Socrate stava per guarire dalla malattia di vivere?
Fu una morte ammirevole, presto percepita come uno scandaloso crimine della democrazia ateniese, che trasformò Socrate in una figura emblematica della libertà intellettuale, un paradigma del vero saggio, un esempio del pensatore disposto a difendere le proprie convinzioni morali contro ogni avversità.