Ecco come sbuffano le borse su dazi e trumpate
Che cosa succede alle borse dopo i dazi di Trump. L'analisi di Polillo

Che cosa succede alle borse dopo i dazi di Trump. L’analisi di Polillo
Se il bel tempo si vede dal mattino, il crollo simultaneo di tutte le borse del Pianeta sta a dimostrare la follia, poco lucida, di Donald Trump.
Da Shangai ad Hong Kong, da Tokyo a Seul, da Milano a Parigi, da Francoforte a Madrid, le perdite non solo sono state ingenti. Ma seguono il tragitto del sole da oriente verso occidente.
Quando a Wall Street suonerà la campana che darà fine alle contrattazioni il diluvio sarà completato. La stessa borsa di Mosca, che nei giorni passati aveva registrato un relativo successo nel nome della dissoluzione dell’Occidente (più 2,5%), oggi restituisce tutto con gli interessi.
Si trattasse solo della normale volatilità di borsa. Ed invece a rendere più cupo il quadro è la simultanea caduta del prezzo del petrolio, in vista di una possibile e temuta recessione; l’aumento degli spread sui titoli sovrani più esposti; i bitcoin che cancellano i guadagni accumulati dalla vittoria di Trump. Insomma: quasi nessuno resta indenne dal contagio della “grande paura” che, in questa fase sta dominando il mondo.
Solo Donald Trump fa sfoggio di ottimismo. Parla di una semplice “cura”, necessaria per rendere di nuovo grande l’America. Ma il dubbio è sovrano e l’antagonismo inizia a serpeggiare.
Cosa succederà è difficile dire. Episodi del genere non si erano mai verificati, in un passato degno di essere preso in considerazione come termine di confronto.
Per avere qualcosa di lontanamente paragonabile bisogna risalire agli anni ‘30, allo Smoot-Hawley Act, “la legge americana che – come ha ricordato Federico Fubini dalle pagine del Corriere della sera – innescò le ritorsioni dalle altre grandi economie e portò alla Grande depressione.”
Sennonché, allora, l’interdipendenza tra le diverse economie non aveva nulla a che vedere con gli intricati e simultanei rapporti che caratterizzano l’economia internazionale. Per cui un semplice starnuto nei pressi della Casa Bianca può dar luogo a polmoniti nelle varie piazze finanziarie asiatiche ed europee.
Restano, pertanto, l’impotenza predittiva e le grandi incertezze per il domani. Ciò che si può dire con una certa sicurezza è che vi sarà una caduta del tasso di crescita dell’economia mondiale, con riflessi, al momento imponderabili, sui singoli Paesi.
“Il quadro previsivo – scrive Banca d’Italia – include una prima e parziale valutazione degli effetti” degli annunci sui dazi, “ma non considera l’eventualità di aumenti ritorsivi da parte delle altre economie”; né sono contemplati gli “eventuali effetti derivanti dall’evoluzione dei mercati internazionali”. Limiti talmente pesanti da rendere quasi inutile qualsiasi previsione.
Le difficoltà non sono solo legate al fatto traumatico implicito nella rottura degli schemi del libero scambio e dell’inizio di una possibile guerra commerciale. La cosa che più colpisce è l’irrazionalità implicita nella struttura dei dazi che Donald Trump ha deciso di applicare ai singoli Paesi.
La misura, com’è noto, è di carattere universale. Nel lungo elenco, riportato dalla stampa internazionale, non sono previsti solo alcuni Paesi, appartenenti all’ex blocco comunista. A partire ovviamente dalla Russia, quindi dalla Bielorussia e dalla Corea del Nord. La motivazione è che sono Paesi già colpiti dalle sanzioni. Sennonché anche l’Iran è stato colpito da sanzioni, ma ciò non ha impedito che allo Stato islamico fossero applicati dazi pari al 10%.
Non è l’unica contraddizione che caratterizza la struttura di quel lungo elenco, composto di 185 Paesi, cui sommare i 27 Paesi europei, raggruppati sotto un’unica voce. La maggior parte, per circa il 60% è colpito da un dazio pari al 10%. Nella casella che va dall’11 al 20% sono collocati 16 Paesi più i 27 appartenenti all’Unione europea. Al top sono i rimanenti 42. L’accanimento maggiore, con le eccezioni che vedremo tra un momento, è rivolto ai Paesi del Sud est asiatico: Cambogia, Laos, Vietnam, Myanmar, Sri Lanka. I dazi previsti superano infatti il 40 %, sfiorando, in alcuni casi, il 50.
Questa è già una prima stranezza. In quest’area dominano infatti le grandi multinazionali dell’abbigliamento, che battono bandiera a stelle e strisce: Nike, Gap, Patagonia, Ralph Lauren, Levi Strauss, Calvin Klein, North Face, Converse, Tommy Hilfiger e via dicendo. Portare i dazi ad oltre il 40 per cento significa ridurre, in prima battuta, i loro margini di profitto. Quindi determinare un effetto domino sui livelli di occupazione di economie appena uscite dal sottosviluppo, ma ancora più che fragili nel loro sentiero di crescita economico – sociale.
Ancora meno comprensibile appare essere quella scelta da un punto di vista politico. Essa, infatti, sembra contraddire agli orientamenti di politica estera, più volte anticipati dallo stesso Trump.
Se l’Indo Pacifico rappresenta un settore strategico da coltivare per contrastare la forza cinese – vecchio e nuovo assillo delle classi dirigenti americane – colpire Taiwan (che si vorrebbe difendere militarmente dagli eventuali attacchi) con un dazio del 32% non è certo la migliore delle idee. E lo stesso vale per i principali alleati degli Stati Uniti, come il Giappone (24%), lo Sri Lanka (36%), l’Indonesia o la stessa Tailandia (36%) già fin troppo vicina alle posizioni di Pechino.
Senza contare poi le vere e proprie stranezze che hanno ingolosito la grande stampa internazionale. Tassare le isole Heard e McDonald, con un dazio del 10%, che si trovano in pieno Oceano antartico e sono abitate solo da foche, pinguini e trichechi, non solo è surreale, ma dimostra l’approssimazione con cui i tecnici di Donald Trump hanno lavorato nel predisporre la lista di costrizione. Analogamente scegliere il Regno del Lesotho o le isole di Saint Pierre e Miquelon come le principali vittime: addossando loro un dazio pari al 50% è operazione tanto incongrua, quanto controproducente.
Il Regno è il terzo Stato più piccolo al mondo, dopo San Marino e Città del Vaticano. Si trova in mezzo al Sud Africa, senza alcuno sbocco al mare. La sua economia è di pura e semplice sussistenza, quindi ha ben poco da importare. Lo scorso anno, i beni acquistati negli USA sono stati pari a 2,8 milioni di dollari. Invece, esporta molto, grazie alla presenza delle grandi compagnie americane – Gap in particolare – nel tessile ed alla produzione di diamanti. Nel 2024, l’export è stato pari a 237,7 milioni di dollari.
Le isole di Saint Pierre e Miquelon, a loro volta, fanno parte di un arcipelago, composto da 17 piccole isole, a largo della costa canadese, che amministrativamente dipendono dalla Francia. Nel 2017 aveva una popolazione di 6.274 abitanti, su una superficie totale di 242 kmq. Appena più grande del comune di Milano. In passato, la sua economia era legata alla pesca e successiva commercializzazione del merluzzo. Attività venuta progressivamente meno a seguito dei contrasti con i suoi potenti vicini: l’America da un lato che aveva imposto una riduzione del perimetro di intervento ed il Canada, a sua volta, ostile ad uno sfruttamento eccessivo di quei mari. A questa piccola comunità Trump ha imposto un dazio pari al 50%. Il Fondo monetario non fornisce alcuna informazione sulla loro economia.
Svarioni, come quelli appena ricordati, dovrebbero trovare giustificazione in una specie di formula (l’algoritmo di Trump) caratterizzata da totale assenza di qualsiasi logica economica. Per calcolare l’ammontare del dazio, infatti, è stato fatto il rapporto tra l’entità del deficit commerciale americano e il valore complessivo delle relative importazioni. Nel caso del Regno del Lesotho, ad esempio, questo rapporto è superiore al 100% (2,8/237,7) approssimato al 99%. Dividendo per 2, per dimostrare la grande magnanimità dell’Amministrazione americana, si ha l’ammontare del dazio destinato a colpire le nuove importazioni verso il mercato interno, a partire dal presunto “giorno della liberazione”.
Ma è proprio così? Per la verità – ecco una seconda incredibile stranezza – non sembrerebbe. Esaminando i dati del FMI sul commercio estero americano, per l’anno 2022, è possibile ottenere una fotografia della ripartizione geografica del surplus e del deficit della bilancia commerciale americana.
Nel complesso le importazioni sono state pari a 3,2 trilioni di dollari. Le esportazioni a 2. Il conseguente deficit è risultato essere di 1,2 trilioni. Naturalmente non tutte le relazioni commerciali sono state caratterizzate dal colore rosso. Con alcuni Paesi gli Stati Uniti sono stati in disavanzo con altri invece hanno fatto registrare un avanzo. Le esportazioni, cioè sono risultate maggiori delle importazioni.
Dei 229 Paesi analizzati, circa la metà sono risultati in debito verso gli Stati Uniti. Le importazioni cioè hanno superato le esportazioni. La restante parte, invece, in credito, per cui era possibile applicare quella stravagante formula (l’algoritmo di Trump) di cui si diceva in precedenza.
Prendiamo ad esempio il caso dell’Australia, nei confronti della quale si vogliono applicare dazi del 10%. Nel 2022 il deficit commerciale di quel Paese verso gli Stati Uniti fu pari ad oltre 14 miliardi di dollari. Quindi l’algoritmo non doveva essere applicato. Lo stesso dicasi per il Belgio (deficit di 9 miliardi), per l’Olanda (38,6), per Singapore (14,5), per la Gran Bretagna (11,3), per l’Egitto (3,3), gli Emirati Arabi (13,9), per l’Argentina (6,1) o il Brasile (14,9). Solo per citare alcuni casi.
L’esame di queste apparenti anomalie svela un dato che non fa onore a coloro che si sono comportati da veri azzeccagarbugli. Sì è provveduto a colpire tutti i Paesi con un dazio del 10%. “Ndo cojo, cojo”: si dice a Roma. Salvo aumentare l’aliquota in quei casi in cui il vantaggio comparato delle relazioni internazionali non era a favore di Donald Trump. Marchingegno che fa balenare una mancanza di serietà evidente. Che il mercato ha perfettamente intuito, spaventandosi e reagendo alla sua maniera. Votando, con il diluvio delle vendite.




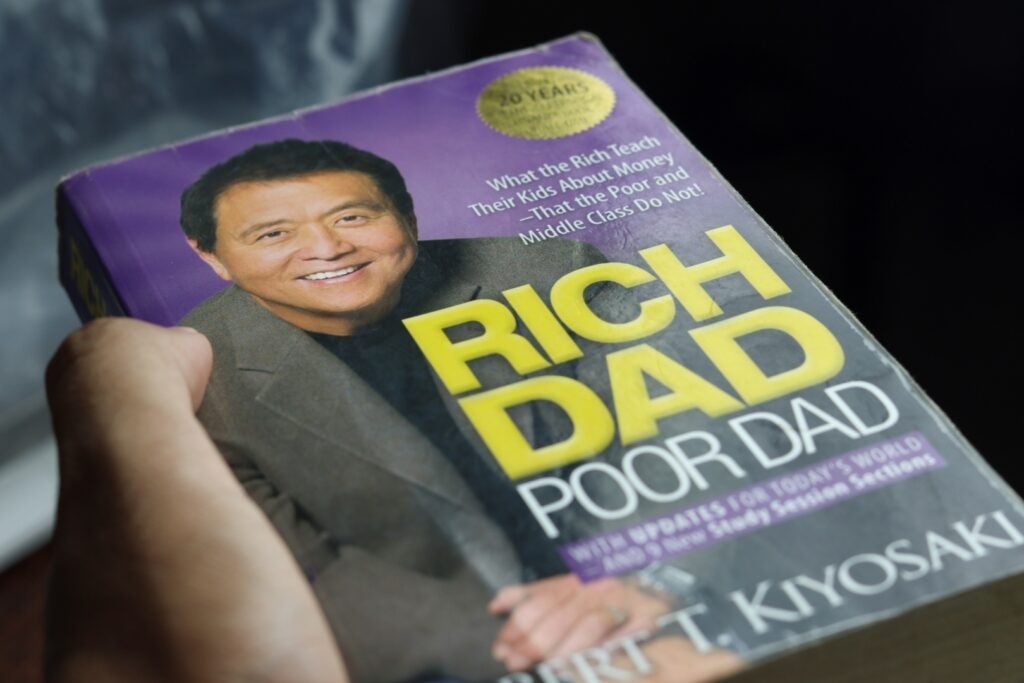























![Giornata della Terra 2025, alla scoperta di 12 storie di fuoriclasse in campo e in rete per prendersi cura del pianeta e di tutti noi [EBOOK]](https://cdn-magazine.startupitalia.eu/wp-content/uploads/2025/04/18095613/WhatsApp-Image-2025-04-17-at-16.27.25-1-1024x516.jpeg?#)


















![Pino Allievi, Gp Arabia Saudita F1 2025: “Il miracolo di Leclerc” [ VIDEO ]](https://www.circusf1.com/f14/wp-content/uploads/2025/04/Pino_Allievi_Arabia_Saudita_F1_2025.jpg)


