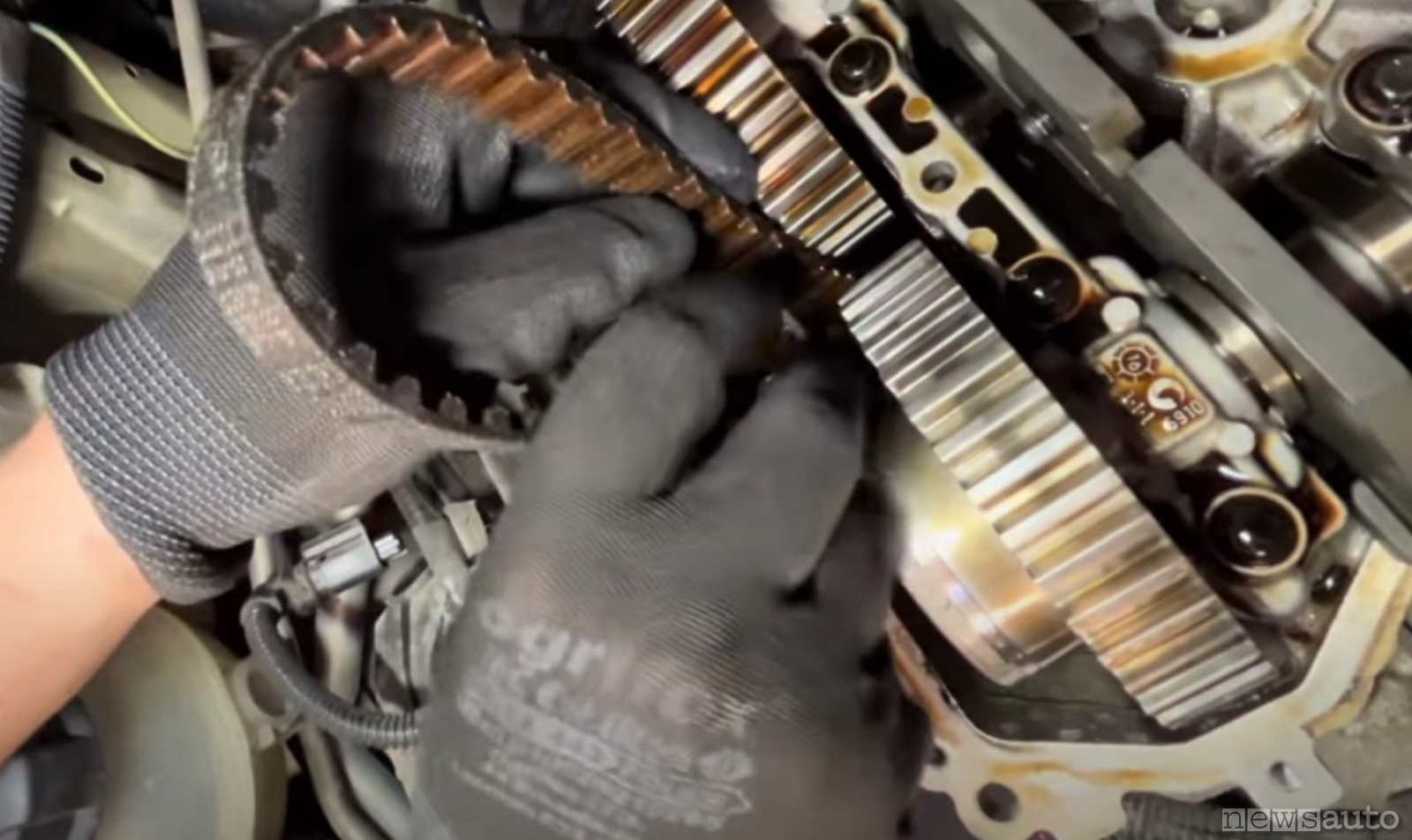Roma conquista gli Iberi: la fine di una civiltà
Quando si estinse la cultura iberica? Sebbene sia logico porsi questa domanda, la verità è che non abbiamo una risposta chiara. Questo perché la dissoluzione del mondo iberico e l'assimilazione della mentalità romana, della sua lingua, religione e tradizioni (ciò che conosciamo come romanizzazione) fu un processo che durò secoli. È curioso che molti degli elementi materiali che associamo automaticamente agli Iberi, come le ceramiche con decorazioni figurative, le monete e le iscrizioni in alfabeto iberico, provengano per lo più da un periodo in cui i Romani dominavano già gran parte di questo ambito culturale.La penetrazione dello stile di vita straniero tra gli Iberi non fu regolare. I conquistatori si sforzarono di controllare prima le zone che più li interessavano: la fascia costiera mediterranea, i centri urbani strategici come Tarraco o Cartago Nova, le zone minerarie come la Sierra Morena, le terre fertili come quelle della valle del Guadalquivir e le vie di comunicazione come la via Hercúlea, che attraversava la penisola dai Pirenei a Gadir (l'attuale Cadice) e che ribattezzarono via Augusta. Nel resto del territorio iberico, gli indigeni mantennero a lungo i propri costumi, le proprie istituzioni e la propria lingua.L'arrivo dei conquistatoriL'anno 237 a.C. segnò l'inizio della fine per il mondo iberico e le altre culture peninsulari. In quella data, le armate di Amilcare Barca sbarcarono a Gadir, decise ad ampliare i domini di Cartagine e a riempire le casse, vuote dopo la sconfitta subita dai Romani nella prima guerra punica. Da lì diedero inizio a una serie di campagne militari che, inevitabilmente, finirono per metterli nuovamente in contrasto con Roma, l'altra superpotenza mediterranea. L'attacco dei Punici alla città di Sagunto, alleata dei Romani, fu il pretesto per questi ultimi per sbarcare in Hispania, decisi a fermare i nordafricani. Iniziava così la seconda guerra punica, che ebbe nella penisola iberica uno dei suoi teatri principali.In questo scontro, entrambe le parti fecero uso e abuso degli indigeni, in un gioco di alleanze e strategie in cui questi ultimi furono i veri perdenti. Dopo la sconfitta cartaginese, infatti, il Senato romano decise che i suoi eserciti non potevano abbandonare una terra che si era rivelata una fonte inesauribile di metalli, prodotti agricoli, guerrieri e schiavi. Iniziò così una guerra di conquista spietata che durò due secoli, fino al 19 a.C., quando caddero le ultime roccaforti cantabriche e asturiane.Il dominio dell'area propriamente iberica fu considerato completato molto prima, intorno al 190 a.C. Ma questa era solo la teoria, come dimostrano le ripetute incursioni del capo lusitano Viriato, che a metà del II secolo a.C. trovò il sostegno di molte città iberiche della Betica, una zona che si supponeva fosse controllata da Roma da decenni. La conquista romana influenzò il mondo iberico in modi molto diversi.In termini politici, l'arrivo di eserciti stranieri nel III secolo a.C. interruppe il naturale evolversi dei popoli iberici, che sembravano immersi in un processo di formazione di nuove entità, che raggruppavano territori sempre più estesi sotto un forte potere personale di tipo quasi monarchico. Esempi di ciò sono il regolo Culchas, che nel 209 a.C. dominava ventotto città della Turdetania (fondamentalmente la valle del Guadalquivir), o Indíbil, che deteneva il potere su tutta l'etnia degli ilergeti, uno dei principali popoli iberici del nord-est della penisola.Le città che resistettero ai Romani furono distrutte, mentre quelle che si arresero senza combattere furono rispettate e la maggior parte dei loro governanti confermati nelle loro cariche. Il motivo è semplice: gli Italici non disponevano di personale proprio per ricoprire tutte quelle cariche, né di legionari sufficienti per proteggerli e soffocare le rivolte che la loro sostituzione avrebbe provocato.Pertanto, la maggior parte delle comunità indigene continuò a godere di un'autonomia quasi totale, purché adempisse ai propri obblighi, che consistevano essenzialmente nel fornire argento e uomini a Roma. Furono proprio queste élite locali le prime ad adottare i costumi, i nomi e le magistrature portati dai Romani; erano consapevoli di vivere una trasformazione che non avrebbe avuto ritorno.Orgoglio e pregiudizioQuando si studia la romanizzazione delle élite indigene, abbiamo a disposizione un documento eccezionale: il Bronzo di Ascoli, un documento in cui viene concessa la cittadinanza romana a una serie di cavalieri iberici (la cosiddetta turma salluitana) per la loro partecipazione alla conquista della città di Ascoli nel 90 a.C. Quando si citano questi guerrieri, viene menzionato anche il nome dei loro padri, e vediamo che tre cavalieri provenienti da Ilerda (Lérida) hanno già nomi romani, mentre i loro padri conservano ancora nomi indigeni. Questo è un dettaglio di estrema importanza, perché ci mostra il momento esatto in cui in quella città si è verificato un cambiamento onomastico che, s

Quando si estinse la cultura iberica? Sebbene sia logico porsi questa domanda, la verità è che non abbiamo una risposta chiara. Questo perché la dissoluzione del mondo iberico e l'assimilazione della mentalità romana, della sua lingua, religione e tradizioni (ciò che conosciamo come romanizzazione) fu un processo che durò secoli. È curioso che molti degli elementi materiali che associamo automaticamente agli Iberi, come le ceramiche con decorazioni figurative, le monete e le iscrizioni in alfabeto iberico, provengano per lo più da un periodo in cui i Romani dominavano già gran parte di questo ambito culturale.
La penetrazione dello stile di vita straniero tra gli Iberi non fu regolare. I conquistatori si sforzarono di controllare prima le zone che più li interessavano: la fascia costiera mediterranea, i centri urbani strategici come Tarraco o Cartago Nova, le zone minerarie come la Sierra Morena, le terre fertili come quelle della valle del Guadalquivir e le vie di comunicazione come la via Hercúlea, che attraversava la penisola dai Pirenei a Gadir (l'attuale Cadice) e che ribattezzarono via Augusta. Nel resto del territorio iberico, gli indigeni mantennero a lungo i propri costumi, le proprie istituzioni e la propria lingua.
L'arrivo dei conquistatori
L'anno 237 a.C. segnò l'inizio della fine per il mondo iberico e le altre culture peninsulari. In quella data, le armate di Amilcare Barca sbarcarono a Gadir, decise ad ampliare i domini di Cartagine e a riempire le casse, vuote dopo la sconfitta subita dai Romani nella prima guerra punica. Da lì diedero inizio a una serie di campagne militari che, inevitabilmente, finirono per metterli nuovamente in contrasto con Roma, l'altra superpotenza mediterranea. L'attacco dei Punici alla città di Sagunto, alleata dei Romani, fu il pretesto per questi ultimi per sbarcare in Hispania, decisi a fermare i nordafricani. Iniziava così la seconda guerra punica, che ebbe nella penisola iberica uno dei suoi teatri principali.
In questo scontro, entrambe le parti fecero uso e abuso degli indigeni, in un gioco di alleanze e strategie in cui questi ultimi furono i veri perdenti. Dopo la sconfitta cartaginese, infatti, il Senato romano decise che i suoi eserciti non potevano abbandonare una terra che si era rivelata una fonte inesauribile di metalli, prodotti agricoli, guerrieri e schiavi. Iniziò così una guerra di conquista spietata che durò due secoli, fino al 19 a.C., quando caddero le ultime roccaforti cantabriche e asturiane.
Il dominio dell'area propriamente iberica fu considerato completato molto prima, intorno al 190 a.C. Ma questa era solo la teoria, come dimostrano le ripetute incursioni del capo lusitano Viriato, che a metà del II secolo a.C. trovò il sostegno di molte città iberiche della Betica, una zona che si supponeva fosse controllata da Roma da decenni. La conquista romana influenzò il mondo iberico in modi molto diversi.
In termini politici, l'arrivo di eserciti stranieri nel III secolo a.C. interruppe il naturale evolversi dei popoli iberici, che sembravano immersi in un processo di formazione di nuove entità, che raggruppavano territori sempre più estesi sotto un forte potere personale di tipo quasi monarchico. Esempi di ciò sono il regolo Culchas, che nel 209 a.C. dominava ventotto città della Turdetania (fondamentalmente la valle del Guadalquivir), o Indíbil, che deteneva il potere su tutta l'etnia degli ilergeti, uno dei principali popoli iberici del nord-est della penisola.
Le città che resistettero ai Romani furono distrutte, mentre quelle che si arresero senza combattere furono rispettate e la maggior parte dei loro governanti confermati nelle loro cariche. Il motivo è semplice: gli Italici non disponevano di personale proprio per ricoprire tutte quelle cariche, né di legionari sufficienti per proteggerli e soffocare le rivolte che la loro sostituzione avrebbe provocato.
Pertanto, la maggior parte delle comunità indigene continuò a godere di un'autonomia quasi totale, purché adempisse ai propri obblighi, che consistevano essenzialmente nel fornire argento e uomini a Roma. Furono proprio queste élite locali le prime ad adottare i costumi, i nomi e le magistrature portati dai Romani; erano consapevoli di vivere una trasformazione che non avrebbe avuto ritorno.
Orgoglio e pregiudizio
Quando si studia la romanizzazione delle élite indigene, abbiamo a disposizione un documento eccezionale: il Bronzo di Ascoli, un documento in cui viene concessa la cittadinanza romana a una serie di cavalieri iberici (la cosiddetta turma salluitana) per la loro partecipazione alla conquista della città di Ascoli nel 90 a.C. Quando si citano questi guerrieri, viene menzionato anche il nome dei loro padri, e vediamo che tre cavalieri provenienti da Ilerda (Lérida) hanno già nomi romani, mentre i loro padri conservano ancora nomi indigeni. Questo è un dettaglio di estrema importanza, perché ci mostra il momento esatto in cui in quella città si è verificato un cambiamento onomastico che, secondo quanto suggerisce questa iscrizione, deve essere stato generalizzato.
Ma, come dicevamo all'inizio, il processo di romanizzazione nel mondo iberico fu irregolare. Se a Ilerda si diffuse l'uso dei nomi latini, troviamo anche un caso diametralmente opposto. Ad Arjona (Jaén) è stata scavata la necropoli di Piquía, risalente allo stesso periodo, il I secolo a.C. Nella tomba principale del cimitero, accanto ai resti del “principe” lì sepolto, sarebbero stati collocati quelli di un possibile antenato con parte del suo corredo funerario, che comprendeva sei crateri, grandi vasi greci datati al V-IV secolo a.C. In questo fatto si è vista l'intenzione di legittimare gli eredi di un antico lignaggio in un momento in cui la romanizzazione avanzava in modo inarrestabile.
Un elemento chiave in questo processo di romanizzazione fu l'esercito, e questo in due modi. Da un lato, durante la seconda guerra punica e la successiva guerra che oppose il generale romano Sertorio al dittatore Silla (83-72 a.C.),migliaia di giovani iberici si arruolarono volontariamente o forzatamente come forze ausiliarie dell'esercito romano, dove conobbero, adottarono e assimilarono molte usanze italiche. D'altra parte, in Hispania furono fondate città romane per insediare i legionari congedati._250507175113_800x888.webp)
Se diamo credito allo storico greco Appiano di Alessandria, la prima di queste città fu Italica (Santiponce, Siviglia), dove già nel 205 a.C. Scipione l'Africano insediò i soldati feriti nella battaglia combattuta a Ilipa contro i Cartaginesi. A questa città ne seguirono molte altre, tra cui spicca Carteia (San Roque, Cadice), che nel 171 a.C. divenne la prima colonia latina fuori dall'Italia e dove si insediarono quattromila liberti, figli di soldati romani e donne spagnole. Troviamo nuove fondazioni anche più a nord, come Valentia (Valencia), fondata nel 138 a.C., dove si stabilirono i veterani delle guerre lusitane.
Sebbene la maggior parte di queste città fossero state fondate su insediamenti indigeni già esistenti, fin dall'inizio divennero centri di romanizzazione di primo ordine, essendo “piccole Rome” che estendevano la loro influenza su vaste zone circostanti. Anche negli altri insediamenti iberici si nota una progressiva influenza straniera. Ciò è più evidente nelle città più grandi, dove risiedevano le élite aristocratiche indigene, i primi gruppi sociali locali che adottarono lo stile di vita romano.
Questo fatto si rifletteva nelle abitazioni: erano sempre più frequenti le case costruite alla maniera romana. In esse compaiono elementi decorativi tipicamente italici, come i pavimenti a mosaico, di cui abbiamo un esempio notevole: quello rinvenuto nell'Alcudia di Elche, datato al I secolo a.C. e che contiene diversi nomi propri iberici, ma già scritti in latino.
Templi e credenze
Le nuove mode architettoniche si trasferirono anche ai santuari e ai luoghi di culto, dove sorsero templi di pianta classica che includevano elementi nuovi come capitelli, antefisse e tegole piane. Tra i più noti dell'area iberica, tutti risalenti al II e I secolo a.C., figurano i due templi di La Encarnación (Caravaca, Murcia), quello del Cerro de los Santos (Albacete) o quelli di Sant Julià de Ramis e Ullastret (Gerona). In questi templi e santuari troviamo anche testimonianze di sincretismo religioso, ovvero di fusione tra le credenze iberiche e quelle portate dai Romani. A
Torreparedones (Castro del Río-Baena, Cordova) è stata rinvenuta una testa femminile sulla cui fronte era incisa l'espressione dea caelestis, il nome che i Romani davano alla dea fenicio-punica Tanit e che, a sua volta, sarebbe la trasposizione di una divinità femminile indigena a noi sconosciuta.
In altri santuari, gli Iberi continuarono con la tradizionale offerta di ex voto, ma questi ultimi subirono una modifica estetica. Lo vediamo nel Cerro de los Santos, dove si nota un cambiamento nell'abbigliamento delle sculture in pietra: ora gli uomini indossano il pallium romano, un indumento simile alla toga.
Come dicevamo all'inizio, la ceramica con decorazioni figurative è in gran parte contemporanea alla presenza dei Romani, anche se si ritiene che questi ultimi non abbiano avuto nulla a che fare con la sua nascita. Ciò che è stato rilevato nel I secolo a.C. è un aumento delle rappresentazioni simboliche e mitologiche tipiche delle popolazioni indigene, forse per rafforzare le loro credenze ancestrali, che vedevano minacciate da quelle dei nuovi arrivati.
Arte, scrittura, moneta
Un'altra manifestazione artistica che mostra chiaramente l'influenza romana è la scultura, che gradualmente adottò motivi ed estetiche italiche. Tra gli esempi più evidenti abbiamo le sculture funerarie rinvenute a Osuna (Siviglia), dove si distinguono due serie diverse. La prima, datata tra il III e il II secolo a.C., mostra figure tipicamente iberiche, mentre la seconda, risalente all'inizio del I secolo a.C., rappresenta legionari e altri personaggi già con abiti romani. Nonostante la distanza cronologica tra i due gruppi non sia molto grande, le differenze tra l'uno e l'altro sono evidenti.
La scrittura iberica è uno degli elementi più riconoscibili di questa cultura e, sebbene i suoi primi esempi risalgano al V secolo a.C., con l'avanzata dei Romani il suo uso si estese alle zone iberiche dell'interno dove prima non era presente. Non solo: fu utilizzata anche su nuovi supporti, ad esempio sulle stele funerarie come quella di Sinarcas (Valencia) o nelle iscrizioni pubbliche, di cui abbiamo un esempio preziosissimo nell'architrave bilingue di Sagunto, con la riga superiore in caratteri latini e quella inferiore in scrittura iberica. Purtroppo, gli studiosi non riescono a mettersi d'accordo sul fatto che i due testi dicano la stessa cosa.
Come la scultura, anche la moneta conobbe un periodo di espansione a partire dalla seconda guerra punica: bisognava pagare le tasse e i romani le volevano in argento sonante. Il momento culminante della coniazione indigena si colloca tra la fine di quella guerra e il 72 a.C., epoca in cui i tipi o le figure che appaiono sulle monete evolvono verso modelli italici, mentre nelle iscrizioni si adotta il latino.
Curiosamente, uno dei centri di diffusione della moneta indigena furono le nuove città che sorgevano ovunque, in cui viveva una popolazione mista iberico-romana. Fu il caso di Baetulo (l'attuale Badalona), fondata dai Romani all'inizio del I secolo a.C., che coniò monete con figure iberiche e con il nome iberico di Baitolo.
Come vediamo, i diversi aspetti della cultura iberica si dissolvero nel mare culturale romano in modo lento ma inesorabile. Alcuni resistettero, altri collaborarono. Ma la fine fu la stessa per tutti: i loro tradizionali modi di vita divennero un lontano ricordo che svanì poco a poco nella memoria degli anziani.