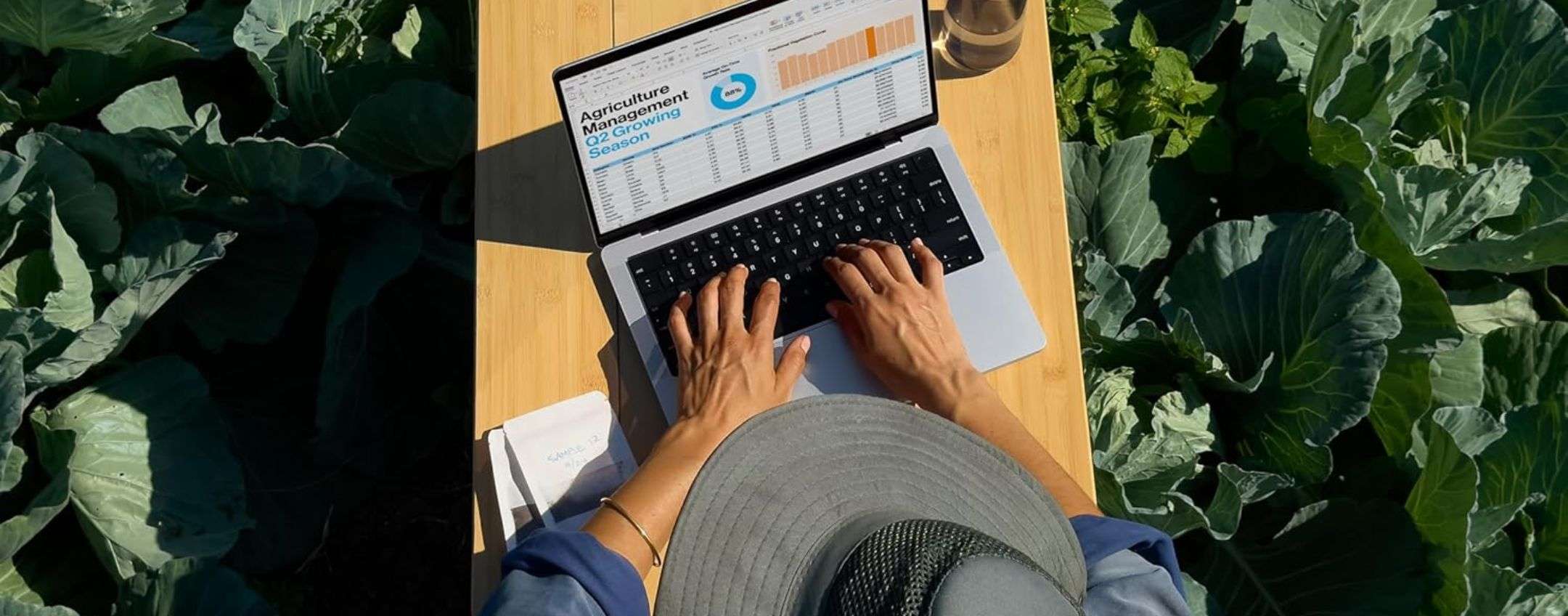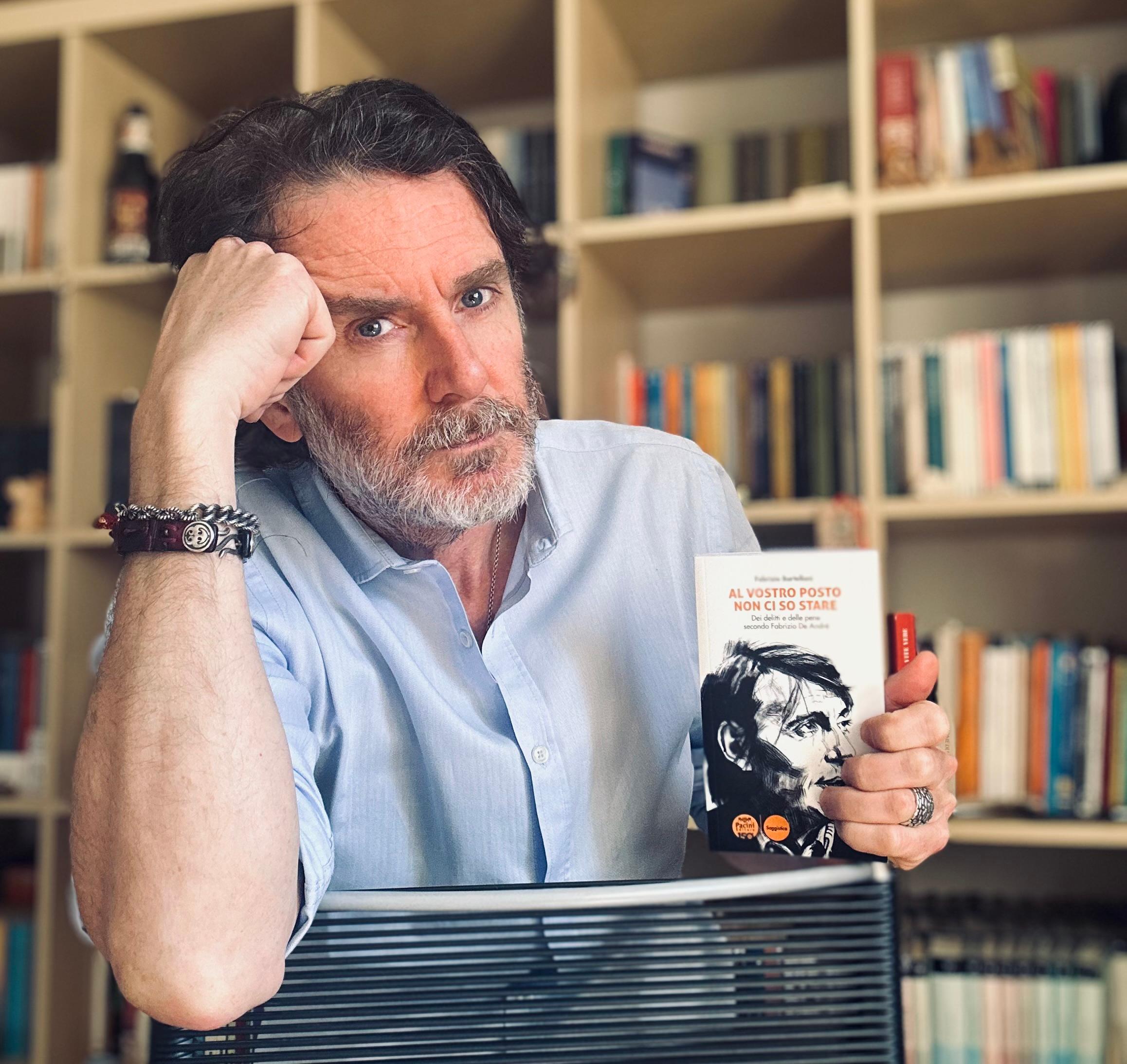Nel Mezzogiorno vive un terzo degli italiani, ma si produce soltanto un quarto del prodotto nazionale. Servono concorrenza, competitività e legalità | L’analisi di Roberto Rustichelli, presidente AGCM
Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è intervenuto in qualità di relatore all’evento Sud Chiama Europa, organizzato a Napoli il 9 maggio 2025 dall’Osservatorio economico e sociale Riparte l’Italia e patrocinato dal Comune di Napoli. In particolare il presidente Rustichelli ha tenuto l’intervento finale dell’evento, che riportiamo integralmente. “Buonasera a tutti. […] L'articolo Nel Mezzogiorno vive un terzo degli italiani, ma si produce soltanto un quarto del prodotto nazionale. Servono concorrenza, competitività e legalità | L’analisi di Roberto Rustichelli, presidente AGCM proviene da Osservatorio Riparte l'Italia.

Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è intervenuto in qualità di relatore all’evento Sud Chiama Europa, organizzato a Napoli il 9 maggio 2025 dall’Osservatorio economico e sociale Riparte l’Italia e patrocinato dal Comune di Napoli.
In particolare il presidente Rustichelli ha tenuto l’intervento finale dell’evento, che riportiamo integralmente.
“Buonasera a tutti.
Ringrazio il prof. Balestra per l’invito e saluto tutti i relatori e i partecipanti a questa importante giornata di studi.
Ritengo che occasioni come questa possano essere particolarmente fruttuose per l’approfondimento di temi che oggi più che mai assumono rilievo centrale, a maggior ragione in una fase segnata dall’eclissi del processo di globalizzazione e con il sistema del commercio internazionale scosso dall’introduzione di un pervasivo reticolo di dazi, che distorcono il confronto concorrenziale tra imprese e tra Paesi.
Occorre, dunque, un importante sforzo congiunto di Istituzioni, policy maker e parti sociali per disegnare concrete ed efficaci strategie di sviluppo per la “ripartenza”.
Nel corso del mio intervento vorrei condividere con voi alcune riflessioni sul tema a cui è dedicata questa giornata:
- in primo luogo,evidenziando – a partire da alcuni dati relativi all’economia meridionale – come una efficace politica della concorrenza giochi un ruolo essenziale per ridare slancio a un territorio chiamato a misurarsi con la strutturale fragilità del settore produttivo, ma anche per rafforzare i diritti di cittadinanza delle comunità locali;
- in secondo luogo, illustrando gli interventi di advocacy e di enforcement che più direttamente sono connessi allo sviluppo del Mezzogiorno;
- in terzo luogo, rivolgendo lo sguardo al ruolo che può svolgere, al fine di rafforzare l’economia meridionale, il rating di legalità rilasciato dall’Autorità.
****
Sul divario tra Mezzogiorno e resto del Paese e sul contributo che la concorrenza può dare allo sviluppo economico e civile dei territori.
- Negli oltre 160 anni trascorsi dalla proclamazione dell’Unità d’Italia non sono mancati bilanci, stime e rapporti sullo stato del divario economico, industriale, infrastrutturale e sociale caratterizzante le macroaree poste ai due poli del Paese. Tra i molti dati disponibili, è sufficiente ricordare che:
i) da decenni il PIL pro capite nelle regioni meridionali è poco più della metà di quello del centro Nord[1], anche se vi sono recenti segnali incoraggianti, come dirò tra poco;
ii) nel Mezzogiorno vive un terzo degli italiani, ma vi si produce soltanto un quarto del prodotto nazionale lordo.
Si tratta di un divario di sviluppo che frena la crescita del nostro Paese e, in verità, non solo del nostro Paese: poiché il Meridione è il territorio arretrato più esteso e popoloso dell’Euro-zona, il suo rilancio non è soltanto un tema italiano, ma direi anche e soprattutto una questione europea[2].
- Esso non può essere colmato con interventi di natura assistenziale o con misure aventi carattere redistributivo, ma richiede politiche volte a stimolare lo sviluppo delle regioni meridionali.
Molto opportunamente, dunque, il PNRR ha previsto l’obiettivo di destinare proprio al Sud il 40% delle risorse disponibili. Tale quota, pari a 82 miliardi, rappresenta un’opportunità unica che, se proficuamente sfruttata, potrà dare avvio a una nuova stagione di convergenza tra Sud e Centro Nord.
Vorrei anche aggiungere che, pur a fronte dei dati riportati, più di recente non sono mancati alcuni segnali positivi provenienti dall’economia meridionale[3]. Mi riferisco, tra l’altro, al fatto che:
- nel periodo successivo alla pandemia, il Mezzogiorno ha conseguito risultati migliori di quelli dell’intera economia italiana; il prodotto e l’occupazione sono infatti cresciuti più della media nazionale;
- nel campo della tecnologia si sono consolidati poli specializzati nella produzione di semiconduttori e microsistemi, come pure nei settori aerospaziale e farmaceutico (si pensi all’industria dei semiconduttori nell’area di Catania, all’attività in campo aerospaziale localizzata in Campania e in Puglia, nonché al notevole sviluppo del settore farmaceutico che si registra nella stessa Campania, che ha sostenuto l’export meridionale nell’ultimo quinquennio, risultando primo nel Mezzogiorno e settimo a livello nazionale per numero di addetti in ricerca e sviluppo)[4];
- seppur in calo nell’ultimo anno a causa delle difficoltà di comparti strategici come automotive e oil, l’export meridionale supera i livelli del 2019, registrando, in base all’ultimo check-up di Confindustria, un significativo aumento[5];
- un ispessimento del tessuto produttivo, comune a tutte le regioni della macroarea, è comprovato dal progressivo incremento del numero delle società di capitali, che superano le 425 mila unità[6].
- l’impatto complessivo a livello nazionale generato dalla manifattura meridionale risulta maggiore rispetto a quello generato da un investimento in una qualsiasi delle altre aree geografiche italiane.
Nel complesso, tali dati confermano l’esistenza di un potenziale di sviluppo del Mezzogiorno che può essere liberato con politiche appropriate[7], dando così continuità alla ripresa dell’economia meridionale.
- Nel novero delle politiche volte a stimolare lo sviluppo e a migliorare la capacità competitiva del Meridione, un ruolo centrale è svolto dalla promozione della concorrenza nel quadro normativo e amministrativo.
Come comprovato da numerosi studi[8], assetti regolatori ben disegnati, proporzionati e non ingiustificatamente restrittivi della libertà di iniziativa economica generano enormi benefici per le imprese e per i cittadini in termini di innovazione, di reddito, di occupazione, di mobilità sociale, peraltro frequentemente senza costi per il bilancio pubblico.
La stessa OCSE ha ripetutamente messo in luce che una riforma organica della regolazione dei mercati, volta ad eliminare le disposizioni che non sono espressione di una reale tutela di interessi generali, costituisce un imprescindibile fattore di crescita economica. Un programma di regolazione ben strutturato e adeguatamente applicato conduce, infatti, ad un abbassamento dei prezzi e ad una più ampia scelta per i consumatori, aiuta a stimolare l’innovazione, gli investimenti e la creazione di nuove imprese, sostenendo lo sviluppo economico e la diffusa creazione di posti di lavoro[9].
Di qui l’importanza di promuovere un processo competitivo effettivo e dinamico al quale le imprese possano prendere parte. Solo così si possono liberare le energie migliori, aumentare la produttività e, con essa, la ricchezza del Mezzogiorno.
Per altro verso, è importante sottolineare che la promozione della concorrenza non è funzionale soltanto alla crescita economica, ma presenta un intimo nesso con lo sviluppo civile delle comunità locali.
Come riconosciuto dalla Corte Costituzionale[10], esiste un legame profondo e virtuoso tra la promozione del mercato e i diritti dei cittadini.
Il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali può dare, infatti, un contributo prezioso alla tutela di alcuni diritti fondamentali che vanno oltre il tradizionale perimetro del consumo di beni e servizi, per attingere a sfere più ampie di partecipazione civile e sociale.
2. Gli interventi di advocacy e di enforcement dell’Autorità nella prospettiva del Meridione
Nella consapevolezza del contributo benefico che la promozione della concorrenza può dare sia in termini di condizioni economiche che di qualità della vita civile, l’Autorità è quotidianamente impegnata a segnalare al legislatore le disposizioni ingiustificatamente restrittive e a formulare le proprie raccomandazioni per una riforma della regolazione che sia attenta alle esigenze di buon funzionamento dei mercati.
Non è possibile ripercorrere i tanti interventi di advocacy svolti, ma vorrei almeno menzionare l’ultima Segnalazione ai fini della legge annuale sulla concorrenza pubblicata a gennaio 2025.
In essa, infatti, l’Autorità ha individuato tre aree prioritarie e strategiche su cui il legislatore nazionale dovrebbe intervenire per la crescita del Paese, ma vorrei subito aggiungere che letre aree individuate risultano, in realtà, altrettanto cruciali per il Mezzogiorno: si tratta, in particolare, dello sviluppo pro-competitivo delle infrastrutture energetiche e portuali, dei servizi pubblici locali e del trasporto pubblico non di linea.
Sotto il primo profilo, è evidente l’intrinseca capacità delle infrastrutture portuali di fornire un indotto di lavori, servizi cantieristici e commerciali, offrendo un supporto essenziale per l’import/export, per il turismo, nonché per la salvaguardia della connettività delle isole e delle regioni marittime periferiche.
Del pari, la diffusione e l’ammodernamento delle infrastrutture energetiche costituiscono passaggi fondamentali per rendere effettiva e concreta la transizione verso un’economia sostenibile.
Sotto il secondo profilo, i servizi pubblici locali continuano ad essere largamente impermeabili ai principi concorrenziali e caratterizzati da condizioni di offerta insoddisfacenti con riguardo sia all’efficienza che alla qualità dei servizi, a detrimento degli utenti.
Quanto, infine, al trasporto non di linea, il settore reclama da tempo una riforma organica della regolazione, anche alla luce delle importanti sentenze pronunciate, oltre che dalla Corte di giustizia, dalla stessa Corte Costituzionale che, nel 2024, ha in più occasioni evidenziato i gravi danni arrecati, in termini di benessere collettivo e di diritti fondamentali dei singoli, da un quadro normativo risalente e desueto.
Una razionalizzazione del quadro regolatorio in tali settori appare, dunque, una condicio sine qua non per il superamento dei gap infrastrutturali e delle disomogeneità nei livelli essenziali delle prestazioni che ancora si registrano nel territorio nazionale e, in particolare, nel Mezzogiorno.
Il contributo che la politica di concorrenza può dare allo sviluppo dell’economia del Meridione emerge con altrettanta chiarezza sul fronte dell’enforcement, atteso che talune linee di intervento seguite di recente sono destinate a produrre effetti benefici in ambiti che risultano decisivi proprio per lo sviluppo di questo territorio, quali turismo, servizi portuali, trasporto ferroviario e trasporto aereo da e verso le isole.
Con riferimento al settore del turismo, assume rilievo la recente istruttoria avviata per abuso di posizione dominante e chiusa a dicembre scorso con impegni presentati dalle società che fanno capo a Booking, volti ad assicurare una maggiore autonomia e trasparenza alle strutture ricettive italiane nei rapporti con la suddetta piattaforma, consentendo loro di differenziare le proprie tariffe tra il servizio reso dall’operatore dominante e gli altri canali di vendita online.
In ambito portuale, l’Autorità ha accertato e vietato un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato delle operazioni di movimentazione delle merci tramite container, nonchédelle attività accessorie al ciclo di imbarco e sbarco, tra i terminalisti attivi all’interno del porto di Napoli.
L’intervento in esame ha posto fine a gravi condotte collusive sulle tariffe – perpetrate proprio nel cuore del Mediterraneo – a danno degli spedizionieri e, in ultima istanza, dei relativi clienti.
Parimenti importante, nell’ottica di evitare alterazioni delle dinamiche concorrenziali tali da deludere i bisogni di interconnessione tra le varie aree del Paese, risulta l’indagine conoscitiva sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo dei passeggeri sulle rotte nazionali da e per la Sicilia e la Sardegna, in relazione alla quale l’Autorità ha pubblicato il suo rapporto preliminare.
Merita, infine, di essere menzionata la recente apertura di un procedimento istruttorio per possibili condotte abusive nel mercato del trasporto ferroviario dei passeggeri sulla rete dell’Alta Velocità, sul presupposto che il diritto delle imprese di accedere all’infrastruttura ferroviaria vada riconosciuto a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, in linea con il quadro normativo europeo che ha istituito uno spazio ferroviario unico per l’esercizio dei servizi di trasporto.
Dagli interventi richiamati si evince con chiarezza che:
- il valore strategico delle infrastrutture, delle reti e dei servizi per la coesione territoriale, l’inclusione sociale e la competitività costituisce un punto di riferimento essenziale anche per l’attività dell’Istituzione che rappresento.
- la promozione e la tutela della concorrenza giocano un ruolo centrale nel processo di appianamento delle divergenze nelle performance e nei livelli di godimento dei diritti tra le diverse aree, e contribuiscono a evitare che il Mezzogiorno venga relegato a mera periferia d’Europa.
L’intimo nesso tra politiche pro-concorrenziali e promozione della legalità – il rating di legalità.
Per assicurare un’economia aperta e in libera concorrenza, non è sufficiente che vi sia un quadro regolatorio adeguato e una concorrenza effettiva tra le imprese.
È altresì indispensabile che le regole siano conosciute e rispettate da tutti: non solo quelle che presiedono al corretto funzionamento del mercato, ma l’insieme delle regole e dei vincoli giuridici cui soggiacciono le imprese operanti nell’ordinamento.
Il sostanziale, uniforme ed omogeneo rispetto della legalità costituisce, infatti, la pre-condizione della parità concorrenziale tra le imprese che l’Autorità è chiamata a tutelare, affinché siano quelle più efficienti a prevalere.
L’Autorità crede fermamente nell’intimo nesso esistente tra politiche concorrenziali e promozione della legalità.
Infatti, una più radicata sensibilità etica delle imprese verso l’osservanza delle leggi accresce la possibilità che il confronto competitivo possa svolgersi nel rispetto delle regole del gioco.
Per tale ragione, l’Autorità ascrive particolare rilievo al Rating di legalità, istituto che ha in sé enormi potenzialità, specialmente in alcune aree del Paese, come appunto il Mezzogiorno, dove il public procurement, in raffronto alle opportunità fornite dalle commesse private, risulta uno sbocco essenziale per la maggioranza delle piccole e medie imprese[11].
Lo strumento, come noto, premia quelle imprese che agiscono nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, contribuendo ad affermare la cultura della legalità su tutto il territorio nazionale, sia a livello centrale che locale.
Per la prima volta, la lotta all’illegalità è stata “pensata” in chiave incentivante, trasformando il suo rispetto in un prezioso valore aggiunto per le singole imprese.
A tale proposito, i dati raccolti dall’Autorità al 31 dicembre 2024 evidenziano che tra le prime regioni classificate per numero di imprese titolari del rating, due si trovano nel Meridione: la Campania e la Puglia si posizionano, rispettivamente, al quarto e quinto posto tra le venti regioni del Paese, per un numero complessivo di 2755 soggetti economici su circa 15 mila[12].
Il dato non mi sembra affatto di poco conto, considerato che, con l’abrogazione della norma del Codice dei contratti pubblici che istituiva presso l’ANAC un sistema di monitoraggio della “reputazione d’impresa”[13], oggi il rating di legalità rimane il principale misuratore della compliance aziendale che le stazioni appaltanti possono considerare tra i criteri di valutazione degli offerenti.
Ma vi è di più: tale strumento si palesa anche come una concreta opportunità per l’accesso al credito bancario.
La rilevazione annuale 2024 svolta dalla Banca d’Italia in merito agli effetti che il possesso del rating di legalità produce in sede di concessione o di rinegoziazione di un finanziamento registra un incremento del 26,4% di imprese titolari di rating finanziate.
Del resto, e con questo mi avvio a concludere, la sostanziale valorizzazione dell’istituto si rinviene, altresì, nella prospettiva di alcune leggi regionali che, nel corso degli anni, hanno cominciato a promuoverne l’impiego al fine di diffondere la cultura imprenditoriale della legalità.
La stessa Regione che oggi ci ospita, sin dal 2017, tiene conto e promuove il rating anche nei procedimenti di competenza dei propri enti strumentali, agenzie e società partecipate, prevedendo specifiche attività di promozione e divulgazione al fine di incentivarne il conseguimento da parte delle imprese del territorio.
Vi ringrazio per l’attenzione.
[1] Istat, I divari territoriali nel PNRR: 10 obiettivi per il mezzogiorno, 25 Gennaio 2023, consultabile all’indirizzo https://www.istat.it/comunicato-stampa/i-divari-territoriali-nel-pnrr-dieci-obiettivi-per-il-mezzogiorno/
[2] Di qui la necessità che l’Europa, per essere davvero competitiva sulla scena mondiale, riesca a fare tesoro di tutte le sue risorse, attuali o potenziali, richiamando a sé ogni singola periferia del vecchio continente per reagire compatta alle sfide poste dalle recenti perturbazioni geo-politiche, economiche e commerciali).
[3] Banca d’Italia, Economie regionali. L’economia delle regioni italiane. Dinamiche recenti e aspetti strutturali, novembre 2024.
[4] F. Panetta, Eppur si muove: l’economia del Mezzogiorno dopo la crisi, Catania, 19 settembre 2024.
[5] Confindustria-SRM, Check-up Mezzogiorno, 25 marzo 2025.
[6] Ibidem.
[7] Così F. Panetta, cit.
[8] OCSE(2023), Economic Policy Reforms 2023: Going for Growth.
[9] Gli sforzi già compiuti in questo senso nei decenni scorsi hanno avuto effetti positivi: diversi studi, infatti, hanno documento empiricamente i benefici economici della liberalizzazione dei mercati dei servizi. Nel 2024, il livello generale di regolamentazione dell’economia italiana è lievemente migliorato in senso pro-concorrenziale rispetto al 2018. D’altra parte l’Italia, pur avendo una performance migliore della media dei Paesi OCSE, è leggermente peggiorata nel confronto internazionale: mentre nel 2018 si collocava alla quattordicesima posizione su 38 Paesi OCSE in termini di regolamentazione favorevole alla concorrenza, nel 2024 è scesa alla diciottesima posizione. È stato stimato, in particolare, che le liberalizzazioni nei mercati dei servizi introdotte in Italia tra il 2005 e il 2019 hanno portato ad un aumento della produttività del lavoro compreso tra i 3 e gli 8 punti percentuali. Inoltre, la riduzione delle barriere regolamentari all’entrata nei mercati dei servizi è stata associata a una diminuzione dei prezzi pari al 6,5%.
[10] Corte Costituzionale, sentenza n. 36/2024.
[11] Cfr. AGCM, Concorrenza e Mezzogiorno: un’analisi territoriale dell’attività dell’Antitrust, luglio 2011.
[12] Cfr. AGCM, Relazione annuale sull’attività svolta nel 2024, 31 marzo 2025.
[13] Si trattava dell’art. 109, abrogato dall’art. 37 del d.lgs. n. 209/2024.
L'articolo Nel Mezzogiorno vive un terzo degli italiani, ma si produce soltanto un quarto del prodotto nazionale. Servono concorrenza, competitività e legalità | L’analisi di Roberto Rustichelli, presidente AGCM proviene da Osservatorio Riparte l'Italia.